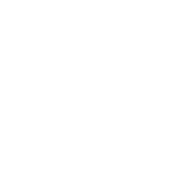servizi per
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
I nostri professionisti offrono piani diagnostici e terapeutici volti alla riduzione delle difficoltà e alla promozione del benessere di bambini e adolescenti
servizi per
L'ETÀ ADULTA,
LA COPPIA
E LE FAMIGLIE
All’interno del Centro Method
opera anche l’equipe di
psicoterapeuti e mediatori
familiari dell’Istituto di
Terapia Familiare Pisa Livorno
servizi per
LA SCUOLA
Servizi di consulenza ai docenti, per coinvolgere la scuola nella pianificazione di percorsi personalizzati e strutturati per i bambini e i ragazzi

La nostra è una équipe multidisciplinare
formata da varie figure professionali, in continua formazione e aggiornamento.
Lavoriamo ogni giorno a stretto contatto, crediamo fortemente nel confronto e nello scambio di idee.
Grazie al lavoro di squadra riusciamo ad avere uno sguardo ampio e a scegliere il miglior percorso possibile per le persone che si rivolgono al nostro Istituto.
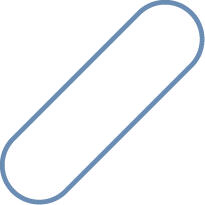
Da chi è formata la nostra équipe?
Psicologo/a, psicoterapeuta, mediatrice familiare e coordinatrice genitoriale, neuropsichiatra infantile, logopedista, neuropsicomotricista, pedagogista clinico, terapista dell’apprendimento.
Centro Method offre
CORSI E SEMINARI PER I PROFESSIONISTI
DELL’AIUTO ALLA PERSONA
L’istituto collabora con S.I.P.P.
(Società Italiana di Psicologia e Pedagogia)
per l’organizzazione di corsi di formazione e seminari
rivolti ai professionisti dell’aiuto alla persona.